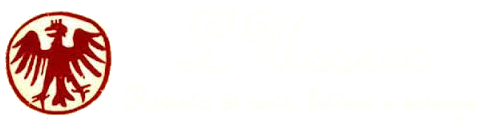Petrini Mansi della Fontanazza E., “Il Patriziato pisano: Spigolature storiche”
IL Patriziato pisano: Spigolature storiche
Emilio Petrini Mansi della Fontanazza[1]
- 1. Introduzione.
Jean-Pierre Labatut ha definito la nobiltà quale «una qualità eminente che solo alcuni uomini possiedono»: anche i teorici italiani, portoghesi e francesi del Cinquecento avevano espresso, più o meno, lo stesso principio. Per quanto concerne la nobiltà toscana tra il Cinquecento e l’Ottocento è opportuno utilizzare un metodo diairetico, con il quale è possibile suddividere il genus rappresentato dalla nobilitas in due singole e differenti species: da un lato, infatti, è rinvenibile la nobiltà comunale, fondata sull’esercizio del potere politico; dall’altro, quella parte della nobiltà che faceva capo all’Ordine Cavalleresco di Santo Stefano, il quale venne costituito per mano di Papa Pio IV, con il patrocinio del governo mediceo, nel 1562, e venne affidato a Cosimo de’ Medici duca di Firenze, futuro Granduca di Toscana, per controbilanciare lo strapotere della vecchia aristocrazia.
Questa suddivisione risulta di particolare utilità al fine di meglio enucleare le singole peculiarità delle due ‘tipologie’ di nobiltà.
Come accennato poc’anzi il governo mediceo utilizzando concessioni riferibili all’Ordine Cavalleresco di Santo Stefano – come l’attribuzione di una commenda di grazia – nobilitò molti privati cittadini che potessero vivere more nobilium e ciò grazie al possesso di un patrimonio personale di una certa importanza. Al riguardo nel 1729, il barone di Montesquieu si fermò in Toscana, ricevendone un’ottima impressione: le sue annotazioni sulla nobiltà della regione saranno le uniche, insieme con quelle sullo Stato pontificio, a produrre nel filosofo non soltanto annotazioni giuridiche, ma anche riflessioni storiche. Egli, infatti, rimase favorevolmente colpito dal fatto che la nobiltà toscana non negasse le proprie origini mercantili: i nobili del granducato svolgevano d’abitudine lavori, come quello doganale, che i loro colleghi francesi avrebbero senz’altro disdegnato. Inoltre il granduca non conferiva abitualmente lettere di nobiltà, ma, dietro esborso di diecimila scudi era possibile essere ammessi nell’Ordine nobilitante di Santo Stefano attraverso una commenda di patronato.
-
2. La commenda di padronato dell’Ordine stefaniano
. Quest’ultimo istituto trova la sua antica origine nel diritto canonico: si donava un ammontare di beni all’Ordine, che ne acquisiva la proprietà tranne l’usufrutto, che spettava al fondatore e a quanti fossero stati indicati come successori; al commendatore spettava, invece, l’onere dell’amministrazione e del buon mantenimento. Il peculio donato sarebbe stato protetto da ogni tassa e dai creditori, oltre che dai rischi di frammentazioni dovute a divisioni ereditarie, assicurando per generazioni il mantenimento delle sostanze familiari. L’aspetto più significativo dell’istituto è il contributo che l’istituto seppe dare per favorire la mobilità sociale all’interno del ceto, infatti il commendatore si trovava promosso alla dignità di nobile, insieme con la propria famiglia. Naturalmente del tutto prevedibile fu la diffidenza che contro questi “ricchi parvenus di casta”, appoggiati dalla casa granducale, venne tenuta da parte di quei soggetti in grado di vantare cinque generazioni di immacolata e ininterrotta aristocrazia e che si videro messi allo stesso livello di plebei arricchiti: i cavalieri di padronato. Una diffidenza che però non ebbe una grande incisività, del resto quasi ogni famiglia della più antica nobiltà poteva ricordare un avo mercante, un ascendente notaio o un lontano antenato che avesse esercitato una qualche arte «vile e meccanica»; e a molti faceva comodo alleare, maritando una propria figlia, la propria vetusta famiglia con nuove, ricche di sostanze; un simile diffuso back-ground anche tra i più nobili impedì atteggiamenti di eccessiva rigidità e chiusura. Differenze tra antichi e nuovi nobili si esteriorizzarono formalmente quasi esclusivamente nelle cerimonie pubbliche: infatti, i cavalieri per giustizia (che avevano provato una ininterrotta nobiltà da almeno duecento anni), precedevano quelli di padronato, ammessi in virtù di fondazione di commenda, questi ultimi, inoltre, preceduti perfino da quelli di grazia (ammessi per concessione Sovrana), spesso di umili origini (v. letterati, poeti, artisti che non disponevano di un patrimonio sufficiente per fondare una commenda). Il sistema delle commende fu instaurato per esigenze strettamente contingenti al momento della fondazione dell’Ordine stefaniano: sia per accrescere il numero di fedeli cavalieri sui quali poter contare nei momenti di necessità, sia per aumentare il più possibile il patrimonio stefaniano.
- 3. Le riforme di Francesco Stefano di Lorena: un imperatore come granduca.
Un revirement deciso nell’amministrazione dell’Ordine e conseguentemente nelle concessioni commendatizie si ebbe con Francesco Stefano di Lorena. Infatti, il fondatore della dinastia degli Asburgo – Lorena aveva nuove e diverse necessità, prima fra tutte quella di rinnovare il prestigio del Culto stefaniano, messo a repentaglio proprio dall’abuso del sistema commendatario. Se al tempo della sua istituzione l’Ordine rappresentava uno strumento del principe per contrastare lo strapotere della nobiltà toscana preesistente, per trasformarsi poi nello stratagemma con cui personaggi di dubbie origini e nobili di scarse sostanze si erano assicurati una posizione sociale ed una rendita fissa, con la Reggenza, nella prospettiva assolutistica che si voleva ripristinare, occorreva riprendere pieno controllo sulle modalità di ammissione e quindi di nobilitazione. Cosi è spiegabile la «legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza» promulgata da Francesco Stefano il 31 luglio 1750, poi pubblicata a Firenze il 1° ottobre dello stesso anno: un netto ridimensionamento del peso istituzionale da attribuire alla «nobiltà civile», il riconoscimento dell’ammissione agli Ordini di Malta e di Santo Stefano quale prova inconfutabile di appartenenza al ceto privilegiato, la distinzione tra nobiltà semplice e patrizia, l’indiscusso valore dei diplomi regi e quindi l’affermazione del principio per cui il processo di promozione sociale dovesse essere demandato al volere sovrano. La normativa se da un lato riprese le disposizioni restrittive, dall’altro non fece che rielaborare la normativa propria dell’Ordine di S. Stefano conferendole la forza di legislazione statuale. Nell’articolo 1° della legge non si accennava ad alcuna distinzione tra nobiltà naturale e civile, ma si elencavano invece quattro possibili fonti di nobiltà, poste tutte sullo stesso piano e rappresentate dall’investitura di un feudo, dall’ammissione a un Ordine cavalleresco, dal conferimento di un diploma del principe, dall’esercizio di una suprema magistratura cittadina. Di fatto, il concetto di nobiltà rimase svincolato dalla titolarità dei diritti politici: «nobiltà» e «cittadinanza» non coincidevano più.
- 4. Le “patrie nobili” toscane.
Il registro della nobiltà venne istituito solo nelle città classificate come «patrie nobili», quattordici in tutto, solo quattro in più (Colle Val d’Elsa, San Sepolcro, San Miniato e Pescia) rispetto a quanto già previsto negli statuti stefaniani. Si introdusse inoltre una distinzione fra due categorie di centri urbani. Un primo gruppo, le sette «antiche città nobili», comprendeva Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra e Cortona, dove l’aristocrazia si poteva distinguere in due ranghi: la «nobiltà semplice», propria delle famiglie che non potevano provare la permanenza continuata nella cerchia dei privilegiati per almeno duecento anni, e il «patriziato», composto invece dalle famiglie che annoverassero fra i loro membri cavalieri per giustizia dell’Ordine di Santo Stefano o che fossero state in grado di provare la titolarità dei requisiti nobiliari per non meno di due secoli. Introducendo la distinzione basata sull’antichità del possesso della condizione nobiliare si seguiva quindi una tendenza presente anche in altre realtà italiane, secondo la quale si identificava il patriziato con la parte dell’oligarchia di più vetusta origine, qualità certificabile dall’esercizio documentato delle maggiori cariche municipali o dal conferimento di patenti nobilitanti. Un secondo gruppo di città, che comprendeva San Sepolcro, Livorno, Pescia, Prato, San Miniato, Colle Val d’Elsa e Montepulciano, poteva avere invece solo un’unica classe di nobiltà semplice. La legge del 1750 incontrò l’ostilità quasi universale delle aristocrazie locali, le quali dimostrarono in ogni modo la loro avversione. Si verificò un vero e proprio «sciopero delle provanze», al punto che si dovettero costringere i più restii ad obbedire a quanto prescritto con la minaccia di privarli dei privilegi finanziari e testamentari di loro spettanza. Nel luglio del 1752 si arrivò persino all’emanazione di un bando con il quale si intimava ai ritardatari di presentare le proprie provanze entro il mese di settembre di quell’anno, pena la definitiva esclusione dal rango nobiliare. Il patriziato fu riconosciuto a chi avesse potuto dimostrare l’antichità bicentenaria del proprio stato privilegiato e la residenza in una delle sette «antiche città nobili». Qui stava dunque l’essenza patrizia: esclusivamente nel possesso legittimo ed ininterrotto per due secoli della nobiltà.
- 5. Il casato Feroni.
Una eccezione significativa a questa posizione di principio fu però rappresentata dall’ammissione del casato dei Feroni.
Si tratta dell’unico caso di conferimento del patriziato per grazia granducale ed è spiegabile solo alla luce della straordinaria ricchezza accumulata in meno di trent’anni. Nel 1673 Francesco Feroni figlio di un tintore di Empoli aveva fatto ritorno da Amsterdam in patria, dove era stato immediatamente ammesso con tutti gli onori nella cittadinanza fiorentina, poi fra i senatori (nel 1674) e nominato depositario e ministro generale della Zecca, infine aveva ricevuto dal granduca «il feudo di Bellavista con titolo marchionale». Il ‘neo’ marchese Francesco Feroni aveva presentato, così, domanda di ascrizione al patriziato per sé, i suoi fratelli e suo figlio fin dal febbraio del 1751, esibendo l’arme, i certificati necessari e il diploma granducale del luglio 1738 che confermava la precedente investitura feudale di Bellavista ad opera di Cosimo III nel 1695. In questo antico diploma si disponeva che l’avo del comparente, il senatore Francesco, con i suoi discendenti, fossero da considerarsi «nobili di vera e generosa nobiltà, ed eguale in tutto e qualunque altra nobiltà proveniente da chiarezza di sangue e da chiarezza dell’antenati». Non solo, nel fascicolo si allegava anche un motu proprio dello stesso Cosimo III dove Francesco veniva proclamato «abile all’abito stefaniano per giustizia ed inoltre dichiarato che il quarto Feroni non possa patir mai eccezione alcuna» e la regolare vestizione era seguita il 17 gennaio 1705. Nonostante quei gloriosi settantotto anni di nobiltà restassero decisamente pochi per aspirare al patriziato, il richiamo all’articolo V della legge, che giudicava l’apprensione dell’abito stefaniano sufficiente per provare la nobiltà «generosa», resero possibile all’interessati potersi fregiare del suo statuto patrizio.
- 6. La perdita della nobiltà.
Ma la nobiltà si poteva perdere? Se sì come? La decadenza dallo status avveniva in due circostanze: se si era riconosciuti colpevoli di un delitto e per l’esercizio di arti «vili e meccaniche». Nel primo caso, ad eccezione della lesa maestà, non si arrecava pregiudizio allo stato nobiliare eventualmente posseduto dai figli del reo nati precedentemente alla sua cancellazione dalla classe nobile (o patrizia) seguita alla condanna. L’esclusione di alcune tra le più diffuse professioni, tra quelle permesse ai nobili, dal rango della nobiltà, disposizione generale dalla quale si eccettuavano unicamente «le Arti liberali, la marcatura grande e l’Arte della seta e della lana, del medico e avvocato, sempre che siano addottorati nell’Università di Toscana», ma è bene puntualizzare come la perdita della nobiltà fu un provvedimento del tutto eccezionale.
In linea di massima, infatti, nei casi dubbi, si preferì mostrarsi concilianti e prestar fede a quanto supposto dai comparenti anziché eccedere in rigore, soprattutto quando si trattano di famiglie dotate di ricchi patrimoni od appartenenti a zone del granducato dove la crisi demografica aveva immiserito la classe nobiliare. In fondo, si diceva, «tutte le famiglie [nobili] aver debbono il loro principio e giova la moltiplicazione e l’avanzamento delle medesime». Il possesso di una laurea dottorale costituì sempre un titolo preferenziale e di speciale riconoscimento da parte della deputazione. Così la professione di avvocato (come quella di medico e giudice) fu ritenuta del tutto compatibile con la condizione nobiliare, nonostante fosse tutt’altro che facile distinguere inequivocabilmente il tipo di esercizio prestato dai singoli avvocati. Quanto alle magistrature pubbliche più prestigiose e tradizionalmente riservate agli esponenti più influenti della Comunità (quale il gonfalonierato e il priorato per giustizia), non fu sempre così semplice valutarne il valore in termini di titolo nobiliare. Inoltre la legge del 1750 si limitava a stabilire come alcune matricole per le Arti, in particolare quelle principali della lana e della seta, non costituissero necessariamente pregiudizio alla condizione nobiliare, a condizione che fossero esercitate con grandi capitali e a livelli elevati. Si ritenevano infatti ammissibili, con particolare attenzione per le Arti della lana e della seta, le pratiche di commercio e di cambio, se esercitate «in digrosso» e per una «somma riguardevole», ma non quelle «del tener bottega per vendere a minuto», e neanche le professioni di speziale, chirurgo, procuratore, notaio, cancelliere ed attuario. Al riguardo mi pare interessante offrire un collegamento con il passato, per evidenziare come una simile ideologia, per cui l’arte illiberale esercitata in grandi dimensioni non fosse deprecabile, radicasse le proprie origini nel pensiero antico, diffusosi – così sembrerebbe – nel periodo del nostro studio senza soluzione di continuità. Infatti, credo del tutto inedita ad oggi, nell’ottica qui adottata, l’esegesi di un passo del De officiis di Cicerone (1.150 – 1.151), dove in riferimento alla mercatura l’Arpinate sottolinea come questa attività dovesse essere considerata sordida se tenuis (ovvero esercitata in bottega) e come al contrario non potesse essere considerata tale, e dunque degna di essere svolta anche dal patriziato, se invece fosse stata magna e copiosa.
- 7. I diplomi di nobiltà.
Come sancito dal primo articolo della legge del 1750, il conferimento di un diploma sovrano di nobiltà era e doveva essere considerato a pieno diritto un titolo costitutivo. Era riconosciuto un valore costitutivo al diploma sovrano solo nel caso in cui avesse conferito un diritto di cittadinanza o di esercizio dei pubblici uffici, la titolarità di un feudo o di qualche altra «funzione onorevole». La legge disponeva che coloro che fossero stati ammessi da meno di cinquant’anni ai primi onori cittadini, potessero registrarsi come nobili soltanto se si fossero imparentati con famiglie dell’aristocrazia locale, se avessero stabilito il proprio domicilio in città e vi avessero acquistato beni e proprietà tali da potersi permettere una rendita consona al rango richiesto. Accanto ai diplomi costitutivi, vi erano quelli che si limitavano ad attestare una «preesistente nobiltà naturale»: il principe aveva cioè riconosciuto un membro della famiglia come appartenente al rango privilegiato, non in virtù di una sua concessione, appunto, bensì per «dichiarazione dell’antica». Seppur non previsti espressamente dalla legge, anche questi documenti dovettero a tutti gli effetti essere considerati probatori, né poteva essere diversamente dal momento che la «nobiltà confessata e riconosciuta dal sovrano si dice più che legittimamente provata». La legge del 1750 contemplò due casi: il riconoscimento automatico per quanti fossero rimasti solo temporaneamente nello Stato; la possibilità di essere iscritti a tutti gli effetti tra nobili o patrizi per tutti coloro che invece avessero deciso di fissarvi il proprio domicilio, previa supplica diretta al granduca. Da un motu proprio di Pietro Leopoldo del 28 luglio 1768, che si dispose una nuova univoca regolamentazione per tutti i forestieri, nessuno escluso, sancendo un principio più rigido di quanto stabilito dalla legge: «i forestieri nobili, con le prove della loro nobiltà preesistente alla loro venuta in Toscana, saranno ammessi dalla deputazione al trattamento nobile e all’uso de’ loro titoli che di prima avessero a termini di giustizia. E se i medesimi vorranno acquistare il domicilio e domandare il registro della classe della nobiltà o patriziato di Toscana saranno da Sua Altezza Reale graziati a proporzione dei loro requisiti e a termini del capitolo ventunesimo della legge del primo ottobre 1750 e in tal caso dovranno spedire e registrare come sopra il diploma di Sua Altezza Sovrana». Generalmente si trova una tavola genealogica appositamente preparata e comprendente dalle cinque alle sette generazioni, strettamente patrilineare (per quanto non sia raro trovare in aggiunta anche l’indicazione dei matrimoni contratti), limitata ai rami sopravvissuti e qualche volta addirittura alla linea diretta di colui che presentava la domanda d’ascrizione.
- 8. Le tavole genealogiche come fonti di cognizione.
L’analisi delle genealogie fa emergere l’esistenza di precise politiche e combinazioni di interessi che univano diverse famiglie: contrarre matrimonio spesso corrispondeva a stipulare una associazione d’affari, se non altro per il giro di transazioni economiche conseguenti al conferimento della dote o al costituirsi di nuovi vincoli di eredità. Nel periodo 1700-1850 a Firenze e Siena tre volte su quattro si sceglieva come partner un proprio concittadino o concittadina; la percentuale di matrimoni contratti con nobili di diversa residenza superava il 60% a San Miniato e il 54% a Cortona. Furono cinquantuno i casati presentati personalmente da donne alla deputazione per ottenere l’ascrizione nei libri d’oro, per l’esattezza se ne contano trentuno per il patriziato e venti per la nobiltà. In assoluto la percentuale è decisamente modesta e per la quasi totalità si trattò di situazioni eccezionali. Tra le più frequenti, l’eventualità che la gentildonna fosse l’ultima rappresentante di una linea altrimenti destinata all’estinzione e quindi, di fronte a una tale emergenza, si rendeva possibile ciò che altrimenti restava stretta prerogativa maschile. Chiedere l’ascrizione per una donna poteva essere comunque un sempre utile riconoscimento ufficiale, poteva assicurarle migliori opportunità per la conclusione di un buon matrimonio, qualora fosse stata nubile, o garantire a una madre un più solido prestigio per i figli.
Alle donne si riservava insomma un ruolo ben preciso: quello di custodire le tradizioni familiari, non solo paterne, ma anche quelle del coniuge, come accadeva nel caso di vedove con figli minorenni.
La quasi totalità dei fascicoli comprende una più o meno accurata descrizione dello stato patrimoniale delle singole famiglie tramite fedi di decime od estimi, copie di testamenti attestanti la titolarità o l’acquisizione di patrimoni, contratti di compra-vendita. La causa principale della povertà nobiliare fu di sicuro l’assunzione di modelli stranieri, che imponevano l’ostentazione di comportamenti all’insegna dello sfarzo, aveva posto in pericolo anche i patrimoni più solidi.
Le convenzioni sociali erano obblighi ai quali si doveva ubbidire nel modo più assoluto, cosicché il fenomeno dell’indebitamento finiva per colpire la stragrande maggioranza degli aristocratici dell’epoca. A questo si aggiunga la tendenza all’aumento dei patrimoni dotali da conferire alle figlie, causata dalla contrazione quasi generale del ceto. Ciò raggiunse estremi tali da divenire il motivo principale del declino di una famiglia. Acquisire la nobiltà poteva causare la rovina economica. Anche la stagnazione economica legata al reddito terriero ebbe effetti quanto mai deleteri. Un certo peso lo ebbe anche il divieto di esercitare le artes non liberali o vili, tant’è che fu avanzata la proposta di riammettere l’esercizio di determinati mestieri, accolta con rescritto nel 1789.
- .10 La lista dei patrizi pisani.
1.D’ABRAMO
- AGLIATA
- AGOSTINI (oggi Agostini Fantini Venerosi Della Seta Bocca Gaetani Grassi, Conte e Nobili)
- DEGLI ALBIZI (fiorente il ramo Patrizi di Firenze)
- BILANCI
- CRECCHI
- FABBRI
- D’ANGELO
- ANSALDI (anche Nobili di San Miniato)
- AULLA
- BARDI (fiorente il ramo patrizio fiorentino, Bardi Serzelli, Conte di Vernio)
- BARTOLI
- BELTRAMI
- BERCI
- BERZIGHELLI
- DAL BORGO (oggi Kinsky dal Borgo, Conti del S.R.I.)
- BRACCI CAMBINI (anche patrizi fiorentini)
- BUONAVOGLI
- CASAPIERI
- CEULI
- CURINI (oggi Curini Galletti anche Nobili di Pontremoli)
- DELLA CROCE
- FINOCCHIETTI (e Finocchietti Fauloni, Conte e Nobili di Livorno)
- FROSINI (Marchesi, Patrizi di Modena e Reggio)
- GAETANI
- GALEOTTI (oggi Galeotti Ottieri della Ciaja, Conte)
- GALLETTI (Conti e Patrizi di Firenze)
- GALLI
- GRASSI
- GRASSOLINI
- GUALANDI CAMPIGLIA (oggi Giuli Rosselmini Gualandi, Conte e Nobili di Siena)
- LANFRANCHI CHICCOLI
- LANFRANCHI LANFREDUCCI
- LANFRANCHI ROSSI
- LANTI
- LEOLI
- MARRACCI
- MASTIANI BRUNACCI (già Taush, Barone e Nobili di Fiesole)
- MINUTOLI (oggi Minutoli Tegrimi, Conti Palatini e Patrizi di Lucca)
- DA MORRONA
- MOSCA
- PALMIERI
- DA PAULE
- POGGESI
- POSCHI (oggi Poschi Meuron, Marchese di Corniano e Pojano, Nobili di Lucca)
- RAÚ
- RONCIONI (oggi Camici Roncioni)
- ROSSELMINI (oggi Giuli Rosselmini Gualandi, Conte e Nobili di Siena)
- ROSSELMINI (di via Santa Maria)
- SANCASCIANI
- SANMARTINI
- SANMINIATELLI (Conte)
- DA SCORNO
- DELLA SETA (oggi Agostini Fantini Venerosi Della Seta Bocca Gaetani Grassi, Conte e Nobili)
- SILVATICI
- DA SANTOPIETRO GUASPERI
- SPRONI (Sporon)
- DEL TESTA DEL TIGNOSO
- TOMEI ALBIANI e GALEFFI
- DEL TORTO
- DA TRIPALLE
- VAGLIENTI
- UPEZZINGHI
Di settantacinque famiglie rappresentate nell’elenco dei Patrizi pisani, attualmente ne risultano fiorenti solo quattordici alcune confluite in un’unica stirpe, alle quali si devono aggiungere le famiglie che ottennero successivamente il decreto granducale prima della chiusura dei Libri d’Oro cittadini, tra cui: gli Adorni Braccesi (Conte), i Castelli (Patrizi di Firenze), i Gagnoni Schippisi Casati (Patrizi di Siena), i Della Gherardesca (Conte Palatino, Conte di Donoratico, di Castagneto, di Bolgheri, di Settimo, di Pietrarossa, Patrizi di Firenze, di Volterra e Nobili in Sardegna) i Ginori Conti (Principe di Trevignano, Principe, Conti, Patrizi di Firenze, Nobile Romano, di Livorno, Don e Donna), i Pandolfini e i Venerosi Pesciolini (Conte) a cui si devono ulteriormente aggiungere i Kinsky dal Borgo (Conti del Sacro Romano Impero) e i Camici Roncioni che non ottennero il decreto di riconoscimento della qualità patrizia ma ne sono i discendenti ed eredi.
I dati genealogici sopra riportati provengono dall’archivio di famiglia e dalla consultazione di opere di chiara fama come l’Enciclopedia Storico Nobiliare Italiana di Vittorio Spreti e le edizioni XXXI° e XXXII° dell’Annuario della Nobiltà Italiana di Andrea Borella.
Ringrazio per le armi che seguono Andrea Borella direttore ed editore dell’Annuario della Nobiltà Italiana.
[1] Marchese della Fontanazza, Conte Palatino, Nobile dei Marchesi e Patrizio di Lucca. Docente di Diritto Nobiliare Comparato all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, titolare dello Studio Legale di Diritto Nobiliare di Viareggio, C.T.U. in Araldica del Tribunale di Lucca.