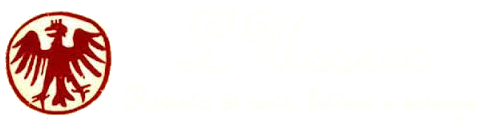Davide S. Amore, “Cultura e società tra Islam e Occidente”
Davide S. Amore
Cultura e società tra Islam e Occidente
Quando andavo a scuola e non ero pienamente cosciente di me stesso, del mondo e delle scelte da compiervi – esattamente come accade ora ai miei figli – la visione unitaria e dominante promossa e propagata dalle istituzioni scolastiche e universitarie era, e continua a essere, che la civiltà, dopo aver posto solide fondamenta nell’antichità greco-romana, rinvigorita nell’Era moderna successiva al periodo oscuro dell’uomo medievale abbarbicato a una concezione religiosa inibitoria, ha trovato in tale Era il suo apogeo esistenziale. Fulcro di tale visione era l’acritica accettazione dello Stato, così come lo intendiamo oggi, quale elemento regolatore della vita sociopolitica ed economica degli esseri umani. Lo Stato non era argomento da discutere. Era, semplicemente. Semplicemente è, e deve essere, o così almeno c’è stato inculcato.
Eppure lo Stato con la “S” maiuscola è, all’interno del percorso storico dell’umanità, solo un capitolo piuttosto tardo, e sperabilmente solo una parentesi. Un vasto numero di uomini in moltissimi tempi e luoghi ha vissuto meglio, raggiungendo apici di civiltà sconosciuti allo schizoide Uomo moderno, senza sapere cosa fosse lo Stato o senza avere gli elementi teorici per concepirlo.
Si potrebbe dire, schematizzando le cose, che nel momento in cui i governanti, piuttosto che opporsi ai banchieri privati che ammassavano una fortuna guadagnando sul denaro (attività invero parassitica in cui nessuno dei Profeti, la pace sia con tutti loro, indulgeva al punto da espellere i mercanti dal tempio o dichiarare l’esattore delle tasse esser figura miserabile), hanno inglobato, fagocitato il sistema bancario, è nato lo Stato moderno, garante non solo del quieto vivere civile, ma fabbricatore di credito, datore di lavoro, stakanovista legislatore e regolatore di ogni minuzia dei rapporti umani che prima erano – giustamente – rimessi all’autodeterminazione dei sudditi.
Nell’epoca dell’Illuminismo e dintorni, la legittimazione dello Stato veniva radicata nel pensiero filosofico (e da lì, eventualmente, nei libri di testo di cui abbiamo accennato all’inizio) da teorici quali Rousseau e Hume: il “buon selvaggio” cedeva la sua arcadica felicità allo Stato – che però nessuno, ai nostri tempi, s’è sognato di testare attraverso un referendum che lo approvasse o meno – attraverso un patto sociale che l’avrebbe protetto dalle mire espansionistiche del suo prossimo.
Nell’Islam non abbiamo la presunzione di elevare quest’epoca a paradigma della realizzazione umana, perché anzi, coerentemente con la Parola di Iddio l’Altissimo, asseriamo: «Oggi ho reso perfetto per voi il vostro Dīn, ho completato per voi la Mia grazia e M’è piaciuto darvi l’Islam come Dīn» (Corano 5, 3). Dove dīn starebbe per religione, ma l’Islam non è la classica religione dedicata esclusivamente al rapporto col sovraumano risolvendosi in un compendio di rituali e ricorrenze abitudinarie. No, l’Islam è un “sistema di vita” che regola anche i rapporti fra gli uomini, una “transazione esistenziale”, locuzione quest’ultima usata dallo Shaykh Abdalqadir As-Sufi, al secolo Ian Dallas, nel tentativo di rendere il complesso significato di questo termine, in quanto dīn è strettamente correlato a dayn, vale a dire “debito/credito” in lingua araba. L’umanità ha dunque raggiunto il suo vertice in ciò che rispetto a noi è passato (salafa-yaslufu).
E nella forma perfetta a cui l’Islam, e dunque gli uomini che lo incarnavano concretamente, ha dato vita nelle prime tre generazioni e poi riprodotto a lungo in modo più o meno corrispondente al modello originario, prima della deriva riformista che ha trasformato i paesi un tempo islamici in specchio opaco e di seconda mano dell’egemonico occidente, lo Stato era una realtà misconosciuta. Tant’è vero che lo stesso termine “Stato” è del tutto assente (come lo è d’altronde “banca”) dal lessico dell’arabo, lingua coranica e lingua franca dell’Islam vincente. “Dawlah”, termine che viene adoperato ai giorni nostri, e abusato da realtà infide come ISIS, che tra l’altro non faceva parte né della fraseologica coranica né di quella profetica, ha un significato diverso, indicato dalla sua radice linguistica, di “circolazione”, “rotazione”, quindi movimento della ricchezza (ancora un concetto economico) comunitaria, dunque opposto alla stasi e alla stagnazione proprie dell’inestirpabile Stato.
Ora, lo Stato che occupa la penisola italica, ossia uno dei tanti nipotini del pensiero illuministico, asserisce che vuole regolare il proprio rapporto con la comunità islamica presente nel territorio nazionale. Il pensiero sottostante è che la comunità islamica è incapace di auto-regolamentarsi.
Alcuni importanti punti fermi, dei paletti, devono essere fissati:
• È obbligatorio disgiungere l’aspetto della sicurezza nazionale da quello dell’interferenza negli affari interni dei musulmani. In Sudafrica, ad esempio, dove cittadine più piccole di Siracusa o Trapani possono contare una quindicina di moschee, numerose scuole ed associazioni islamiche, tutte rigorosamente auto-governate senza alcuna intrusione da parte dell’apparato statale e senza alcuna ripercussione negativa sulla sicurezza del Paese o sulla vita quotidiana delle altre componenti della popolazione. Con buona pace della considerazione che l’Occidente ha di se stesso come faro della civiltà nel mondo (e purtroppo noi occidentali ci pavoneggiamo nutrendoci di tali grossolane affermazioni).
• Il governo locale, regionale o nazionale ha tutto il diritto di prodigarsi a contenere, neutralizzare e azzerare il rischio sicurezza monitorando, reprimendo e rimuovendo dal suolo patrio i sobillatori di disordini e attentati e i loro potenziali bracci armati; e può farlo cooperando in maniera trasparente con la comunità islamica, con tutte le garanzie del cosiddetto “stato di diritto”. Quel che va rifiutato è la tesi che il problema securitario sia endemico alle comunità di musulmani presenti sul territorio e alle istituzioni del loro vivere quotidiano (moschee, scuole, onlus e così via) e che, col pretesto che tale problema vada affrontato solo penetrando capillarmente nel tessuto quotidiano dei musulmani residenti in Italia, si debbano mettere le loro forme d’aggregazione comunitaria, dalla preghiera in giù, sotto interdizione da parte del tentacolare Stato e da questo plasmate per renderle coerenti con la sua visione puramente laica della vita.
• Che cosa c’entra, per esempio, l’imposizione di un medium linguistico nell’orazione del venerdì? Che credenziali ha lo Stato laico per imporlo? La questione securitaria? Quella va affrontata semplicemente trattando i pochi criminali – generalmente ben distanti dalla vita in moschea o da ogni purificante ascesa morale e spirituale, come ampiamente dimostrato dalla cronaca nera di questi anni difficili – come tali, come individui da perseguire attraverso i normali strumenti penali. Forse che viene interdetta la popolazione siciliana generale nel suo agire quotidiano per via dell’attività criminale dei pochi mafiosi? O forse si chiede o si ingiunge agli Hare Krishna o ai confuciani presenti nel nostro Paese di eseguire i propri riti strettamente in italiano? Semplicemente, l’oratore nella preghiera congregazionale del venerdì legge il suo discorso in italiano e poi, quando il rito propriamente detto ha inizio, usa il linguaggio dell’arabo coranico. Se costui dovesse abusare della propria funzione trasformando il minbar (pulpito) in luogo di comizio politico incitante alla violenza, lo si segnali e lo si scacci dalla comunità per il bene di tutti gli italiani, musulmani e non, anzi soprattutto per i primi.
• È inammissibile che i musulmani italiani di nascita siano trattati come cittadini di serie B. Nel “patto per l’Islam” promosso dallo Stato che occupa la penisola italica, il musulmano in quanto tale è identificato con l’immigrato, ossia con il barbaro più o meno incivile che è approdato nei nostri lidi. Questo “estraneo” in terra patria, ci viene detto continuamente, va integrato. Per noi musulmani d’origine italiana che significa integrarsi? Siamo ontologicamente differenti dagli altri italiani (anche se poi, vista l’insensata violenza sulle donne da parte degli italiani puri ai quali nessuna integrazione è richiesta, forse rivendicare una certa qual diversità di fondo non sarebbe poi troppo nocivo)? E forse si insiste con gli Italiani che hanno abbracciato lo sciamanesimo, l’induismo, l’animismo, il taoismo, Scientology o l’astrologia babilonese, come cantava il buon Battiato, per non dire il satanismo, affinché si integrino e dichiarino la loro ferma volontà di integrarsi (qualunque cosa ciò significhi), piuttosto di non commettere crimini o di attentare alla sicurezza nazionale (che magari una tale auto-certificazione da parte di un satanista madrelingua sarebbe un pochettino incongruo)? Cioè, l’Hare Krishna italiano la cui cosmologia è quanto di più lontano si possa concepire dalla tradizione abramitica che accomuna Ebraismo, Cristianesimo e Islam, è più integrato di un musulmano italiano? Ci preme dunque sottolineare enfaticamente, ora e in questo luogo, che noi italiani musulmani ripudiamo come spurio e illegittimo tutto questo vocabolario, fortemente discriminatorio verso di noi, quando lo si cerca di applicare nei nostri confronti, e che non abbiamo bisogno di essere integrati nella realtà in cui siamo nati e cresciuti. E chiediamo altresì alle autorità italiane, ora e in questo luogo, se l’imam di una moschea che fosse italiano di nascita e musulmano debba comprovare la sua italianità attraverso un corso speciale (da estendere magari a un archaka italiano che dirige un rituale di devozione in un tempio indù locale)?
Ma noi andiamo anche oltre, poiché l’Islam notoriamente non conosce prelato o sacerdozio, e forzare la sua peculiarità socio-antropologica entro parametri e concetti puramente cattolici è fuorviante e risponde solo alla logica dell’utilizzo strumentale del problema securitario per orientare il modo in cui i musulmani intendono e praticano il loro modello di vita.
Nell’Islam, si parla di “imamato” maggiore (la guida politica) e di “imamato” minore (quello di chi guida la preghiera congregazionale; letteralmente, sta di fronte, amāma in arabo; come la vita della madre, umm, dalla stessa radice etimologica, sta di fronte, precede, quella della prole che esce dal suo grembo). La funzione dell’imam di una moschea è semplicemente quella di prendersi cura della preghiera comunitaria e della manutenzione ordinaria della moschea. La funzione dell’imām khatīb nel giorno del venerdì è puramente quella di indirizzare un discorso ai membri della congregazione esortandoli al bene e al vero, a meno che non sia la stessa autorità politica a prendersi cura del discorso, in qual caso il contenuto della sua khutbah è moralmente e politicamente vincolante. È però cosa risaputa che in Italia non esiste al momento un’autorità politica islamica autonoma.
Non solo ciò che afferma un imam, compreso l’imām khatīb, non ha valenza politica, nel senso che non vincola affatto i membri della congregazione, ma non ha neanche alcuna valenza legale, nel senso che qualsiasi interpretazione della Legge Rivelata formulata da un imam è puramente espressione soggettiva che non vincola il resto della comunità, essendo il compito di delucidare e far applicare la Legge (rigorosamente in maiuscolo) demandato nell’Islam a giuristi (fuqahā’), mufti e giudici (qudāt). Solo con loro si inizia a configurare un pronunciamento vincolante o quantomeno autorevole. Se dunque l’imam tal dei tali asserisce A dal minbar, io, in qualità di membro della comunità, posso tranquillamente ignorarlo, non darci alcun peso e seguire la mia voce o quella autorevole di un esperto giuridico che con cognizione di causa esprime una posizione su una questione (mas’alah) della Legge rivelata. Di certo lo Stato italiano non può e non deve costringermi a seguire una persona priva di rappresentatività o autorità politica e legale nell’Islam, creando una Chiesa all’interno di ciò che esclude al proprio interno una qualsivoglia gerarchia ecclesiastica e in tal modo interferendo con la mia “libertà di culto”. Del resto in 1300 anni di storia islamica le divisioni settarie tipiche dell’Occidente culminate nella “prima” Guerra dei Trent’Anni (quella tra il 1618 e il 1648 dell’Era volgare, per intenderci, essendo la “seconda” avvenuta tra il 1915 e il 1945) non sono mai state così nette. Certo, anche fra musulmani si sono avute, e sussistono tuttora, guerre fratricide. Al confronto però, le varie “guerre preventive”, “missioni di pace”, “operazioni di peace-keeping”, alle quali il civilissimo Occidente ci ha ormai da tempo abituati, sembrano delle vere e proprie Apocalissi.
Le quattro scuole giuridiche sunnite, ad esempio, non vanno considerate come in conflitto fra loro, come nel caso di certe branche dell’Ebraismo e del Cristianesimo. La tanto demonizzata salafiyyah non è una scuola giuridica, bensì un movimento che mira a emulare le pratiche e gli insegnamenti delle prime tre generazioni di musulmani. Esistono diversi movimenti ideologici fra i cosiddetti salafī, alcuni dei quali più tolleranti altri meno. “Sufismo” è in realtà un termine ampio usato per descrivere la pratica del tasawwūf del tentativo da parte del devoto musulmano di accostarsi quanto più possibile alla Realtà divina, il quale costituiva la maggior parte delle pratiche dedicate allo sviluppo della terza dimensione islamica dell’Ihsān, vale a dire la perfezione o l’eccellenza che ciascun musulmano dovrebbe raggiungere per ottenere la perfezione della fede, anche se oggi, ahimè, v’è parecchia speculazione al riguardo al punto che qualcuno ha avuto la malsana idea di definirlo “esoterismo islamico” (sic!). È errato mettere salafismo e sufismo l’uno all’estremo dell’altro: si potrebbe in teoria tranquillamente avere pratiche “sufi” e allo stesso tempo essere salafī dal punto di vista dell’attitudine esteriore; tasawwūf è una parola non di conio coranico, sicché va definita: va bene, fin quando è legato al Nobile Corano e alla Sunnah autentica, come mezzo per insegnare il timor di Dio, l’amore nei Suoi confronti e lo sviluppo della consapevolezza delle proprie azioni rituali. Diversamente, com’anche nel caso della salafiyyah quando non è corroborata dalla Sunnah profetica del resto, si rischia di cadere in un abisso di superstizioni popolari.
Lo sciismo in origine non fu un’eresia (dottrina basata su interpretazioni contrarie alla ortodossia) né un vero e proprio scisma (uscita, separazione) all’interno dell’Islam, ma una frattura politica derivante da questioni relative alla successione del Profeta, pace e benedizioni divine su di lui, alla guida della comunità dei credenti (Ummah) e nella fattispecie agli avvenimenti che derivarono dall’uccisione del terzo dei quattro Califfi “ortodossi” (rashidūn), ʿUthmān, Iddio sia soddisfatto di lui. In breve, quando ʿAlī, il quarto, diventa califfo, contro di lui si solleva una prima opposizione capeggiata da ‘Aysha, moglie del Profeta (battaglia del Cammello, 656) e poi da Mu‘awiya, governatore della Siria e parente stretto di ʿUthmān, che sfidò ʿAlī nella battaglia di Siffin (657) accusandolo di non aver fatto il necessario per assicurare alla giustizia gli assassini del congiunto. Alla fine la “battaglia” (non v’è stato infatti alcun spargimento di sangue nonostante gli eserciti avversi fossero schierati in forze) si concluse con un arbitrato che diede ragione a Mu‘āwiya. ‘Ali continuò ad esser riconosciuto Califfo, ma dopo di lui tale funzione sarebbe spettata a Mu‘āwiya, il quale inaugurerà la celebre dinastia omayyade (661-750).
Il capo spirituale e temporale della comunità per gli sciiti è l’Imām, termine che essi preferiscono a quello di califfo. Lo sciismo a sua volta si divide in un gruppo maggioritario che crede nella successione di dodici Imam e in un altro che invece si ferma al settimo Imam, ossia gli sciiti imamiti o duodecimani e gli sciiti ismailiti o settimani. Ed è da quest’ultimo che deriveranno i temibili Carmati del Bahrain che nel X secolo terrorizzeranno le carovane dei pellegrini musulmani, fino a saccheggiare la stessa Città Santa di Mecca e rubare la Pietra Nera. Tant’è che mentre l’imamismo, l’ala moderata, sarà religione di Stato dal 1501 in Iran con i Safavidi, l’ismailismo si realizzerà politicamente solo per un breve periodo, con la dinastia dei Fatimidi in Egitto (969-1171).
Ma ancor più estremi furono i kharijiti (gli uscenti, i scismatici) che si separarono dal seguito di ʿAlī, Iddio sia soddisfatto di lui, colpevole d’esser sceso a compromessi durante l’arbitrato di Siffin. Da allora si diedero alla macchia, contraddistinguendosi per la militanza attiva e armata che li portò a compiere veri e propri atti di “terrorismo” ante-litteram (essendo il terrorismo vero e proprio partorito durante gli eventi che si susseguirono alla Rivoluzione francese). Il kharijismo venne sempre perseguitato (lo stesso ʿAlī ne ordinò il massacro a Nahrawan nel 658 dove fu poi ucciso da uno di loro) a causa delle idee estreme e sovversive che predicava. Fra queste: il califfato doveva andare al migliore dei musulmani, “foss’anche uno schiavo negro”; se il califfo si macchiava di colpa grave andava rovesciato con la forza; il musulmano che pecca infine va considerato apostata e dunque messo a morte. Come non farsi venire alla mente i gruppi terroristi moderni quali Al-Qā’idah o Hamās che tanto li ricordano nei metodi? Del resto i gruppi militanti islamisti contemporanei sono stati definiti neo-kharijiti dalla maggioranza delle autorità religiose sia sunnite sia sciite proprio per la militanza armata e per il rigore della loro ideologia.
Tornando a noi, a parte la preghiera congregazionale e il discorso pubblico del venerdì, l’imam non è necessario per le funzioni essenziali della vita islamica: per la nascita o la sepoltura di una persona, per un matrimonio o un divorzio, per l’accettazione dell’Islam da parte di un nuovo musulmano, ecc. Niente vieta all’imam di una moschea, naturalmente, di svolgere funzioni socialmente utili, come visitare detenuti musulmani o coordinare opere di beneficenza e assistenza sociale, purché sia chiaro che lo faccia non come un parroco/vescovo investito d’una qualsivoglia funzione religiosa esclusiva estranea al nostro Dīn. E neppure sono gli imam di una moschea le guide spirituali più significative di una comunità islamica. Tale funzione è riservata infatti ai maestri sufi (e niente vieta naturalmente ad un maestro sufi d’esser anche l’imam di una moschea). Nella gerarchia della guida spirituale, gli imam di una moschea occupano un livello più basso, alla base della piramide, non per questo da disprezzare o da sottovalutare.
Non è dunque intellettualmente onesto proporre la seguente catena di affermazioni: a) i musulmani in Italia sono guidati e rappresentati da una gerarchia pseudo-ecclesiastica, gli imam di moschea; b) i musulmani in Italia devono integrarsi nel tessuto socioculturale italiano; c) ergo, possono dar voce a tale comunità solo gli imam di moschea che hanno ricevuto un attestato di avvenuta integrazione al termine di corsi specifici organizzati all’uopo. Chiediamo più libertà ed autonomia, e più rispetto anche.
Bibliografia
Shaykh Abdalqadir as-Sufi, Root Islamic Education, Diwan Press, Londra, 1993.
Umar Ibrahim Vadillo, The Esoteric Deviation in Islam, Madinah Press, Città del Capo, 2003.
Abdalahaqq Bewley, The Natural Form of Man, Ta-Ha Publisher, Windsor Grove, 2008.
Il Corano, (a cura di) Hamza Roberto Picardo, Newton Compton Editori, Roma, 2015.
Abdassamad Clarke, Follow the Money: Guida musulmana al torbido mondo della finanza, trad. di D. S. Amore, Edizioni Al Hikma, Imperia, 2018.
Discorso dello Shaykh Ahmad ʿAlī al-Adānī all’incontro 100xBalfour tenutosi presso il Dongione normanno di Motta Sant’Anastasia, CT in data 16/12/2017 e disponibile su https:// www.facebook.com/assislassalam/videos/2042247142719455/.